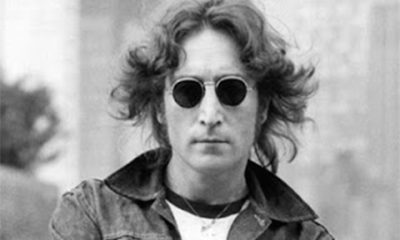Dire che nelle elezioni regionali di Lombardia e Lazio ha vinto l’astensione è un truismo, si capisce. Tutto il resto è noia, dunque? Certo che no. E’ importante capire perché la gente non va a votare, ragionando sperabilmente per segmenti.
I giovani -diciamo dai 18 ai 30 anni- rappresentano una cosa, plasmati come sono da una cultura digitale del tutto pervasiva, di cui la politica non si accorge se non per gli aspetti più superficiali, per i suoi opportunismi propagandistici e le sue potenzialità aggressive (ricordiamoci della “Bestia” di Salvini).
Altra cosa è l’età di mezzo -diciamo dai 30 ai 60 anni- in cui si prende progressivamente coscienza dell’inanità della politica nello svolgimento dei grandi processi che determinano “ciò che conta”, vale a dire lavoro, carriera, riconoscbilità sociale, qualità ambientale, vivibilità insediativa, tanto urbana che rurale. Come dite? Quali sono questi grandi processi? Semplice: si incardinano nella triade economia, tecnologia, cultura. All’età di mezzo, la politica sembra sempre più dissociata da tutto questo, socialmente inutile, del tutto autoreferenziale ma del tutto incapace, allo stesso tempo, di assicurare un corretto funzionamento persino a se stessa .
La terza e la quarta età vivono nello spezzone di mondo che è quello di una “vecchiaia lunga”, a cui non bastano più le riflessioni pacate e sagge della tradizione ciceroniana. La “senectute” attuale esige servizi pubblici efficienti -salute, trasporti, amministrazione- che trovano sempre meno corrispondenza nella realtà quotidiana. La vecchiaia lunga, punto cruciale, rappresenta non la punta della piramide demografica, ma la cupola michelangiolesca della popolazione. Non si assottiglia verso l’alto, come la Tour Eiffel, ma si espande in cima, come un fungo. E tuttavia non basta dire che le nostre popolazioni sono mediamente vecchie e concentrate in misura crescente nella cupola. Occorre sviluppare delle “politiche” conseguenti che riguardino certo le pensioni (età della quiescenza, ammontare dei minimi, adeguamenti al costo della vita, tassazione), ma non si limitino ad esse. La “vecchiaia lunga” ha una sua economia, come tutti sanno, a partire dal mondo produttivo. E ancor più ha una sua cultura che riguarda non solo l’amministrazione della memoria e l’orgoglio della propria esperienza, entrambi fondamentali, ma altresì una idea forte di “vita activa” con la mobilitazione di competenze, professionalità, abilità che non cessano certo d’incanto a 60 o 65 anni. Per non dire di un edonismo dell’età avanzata al quale nessuno vuol rinunciare: turismo e viaggi, letture, cinema (domenica ho cercato col lanternino ma non ho visto che qualche cinquantenne nella sala -che pure era piena- dove sono andato dopo il voto), concerti, teatro, musei, sport, plein air. E per chiudere: chi mai compra un giornale oggi che a Milano non trovi un’edicola neanche se ti metti d’impegno?
Ebbene, dov’è la politica in tutto questo? Perché mai il popolo della “vecchiaia lunga” dovrebbe recarsi alle urne, a fare qualcosa che “non lo riguarda”, sottraendo in una giornata di sole invernale il suo tempo alla passeggiata o al nipotino?
In queste condizioni, in cui per ragioni diverse -per ragioni diverse, sottolineo!- la gente non va a votare, da chi è composto quel 40% che invece a votare ci va? Avanzo un’ipotesi: a partegli irriducibili per i quali il voto continua ad essere un dovere eun privilegio irrinunciabile, a votare ci va lo zoccolo duro dei pariti politici. Quello che votano “a prescindere”. I militanti, i “clientes“, le corporazioni favorite da questo o quel partito, i nostalgici. Insomma, parliamo dell’elettore residuale, qualcuno che, avendo rinunciato a riflettere, a valutare, a ragionare, ma esprimendo il proprio voto “per partito preso”, è incapace di elaborare un giudizio critico sui partiti politici e sulla politica in generale. Ciò lo tiene lontano dal realismo dei programmi, dalla coerenza tra promesse e risultati di governo, dalla moralità dei candidati, dall’efficienza del sistema. Il confronto? Men che meno. Non esiste proprio il dialogo con i competitori che, difatti, vengono di norma considerati non come “portatori di ragioni”, ma come meri stakeholders , “portatori di interessi”. Da qui, a considerare chi non vota come te come un “nemico” il passo è breve, ciò che trasforma la politica in una inenarrabile partita di calcio e la discussione libera e razionale in un gratuito scontro di tifoserie sulla Roma-Milano.
Penso che questo accartocciarsi della politica sul proprio zoccolo duro elettorale sia un punto cieco del processo democratico. Un luogo della geografia politica nel quale gli eletti non rispondono più a nessuno dei loro atti, sia che mentano, sia che rubino, sia che fiancheggino le organizzazioni criminali, sia che cambino casacca in Parlamento o nei Consigli regionali e comunali. Sia che mostrino -talora in modo clamoroso, come vediamo in misura crescente- la loro incuria della cosa pubblica, la loro appossimatività, la rozzezza della loro infarinatura culturale.
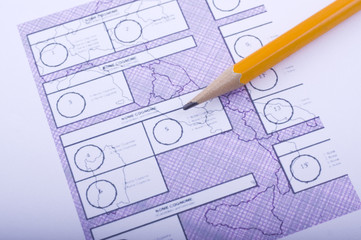

 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa