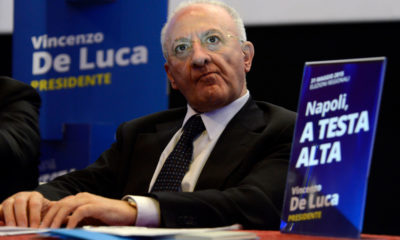“La popolazione residente in Campania, all’1 gennaio 2024, è di quasi 5 milioni e 600 mila persone e rappresenta il 9,5% della popolazione residente in Italia, il 41,7% di quella del Sud e il 28,3% di quella del Mezzogiorno. L’articolazione territoriale della regione è chiaramente caratterizzata in senso urbano. Le città sono 77 in tutta la regione e raccolgono il 56% della popolazione (35,2% la media italiana e 35,4% per quella del Mezzogiorno) mentre il peso delle piccole città e dei sobborghi (171 comuni; 32% della popolazione regionale) è decisamente più ridotto (47,9% la media-Italia). È piuttosto bassa anche la quota dei residenti nelle zone rurali (12,1% a fronte del 16,9% italiano)”. Questi i dati forniti dall’Istat nel rapporto, giunto alla sua seconda edizione, ‘BesT’ dove si delineano i profili di benessere equo e sostenibile per ciascuna delle 20 regioni italiane e per le rispettive province a partire dalla lettura integrata degli indicatori del Bes dei territori.
La Campania, sottolinea l’Istituto, si connota inoltre per una netta prevalenza di popolazione residente nei comuni polo e cintura (82,8%), con valori decisamente più elevati della media del Mezzogiorno (63,9%) e del totale Italia (77,4%). Invece è ridotta l’incidenza delle aree interne: i comuni più distanti dai centri in cui si trovano i servizi essenziali raccolgono il 17,2% della popolazione residente (22,6% in Italia). Nella regione, la città metropolitana di NAPOLI ha un peso preponderante in termini demografici rispetto alle restanti 4 province, raccogliendo il 53,1% della popolazione regionale. Con il contributo delle province di Caserta e Salerno si supera l’88%.
Nel 2023 la dinamica demografica in Campania è in deciso calo. Si registra infatti, spiega il rapporto, una perdita nell’anno di 19.460 residenti (-3,5 per mille) a fronte di una tendenza nazionale di sostanziale stabilità (-0,1 per mille). L’andamento campano è determinato dal segno negativo di entrambe le componenti: quella naturale, con la maggiore perdita (-2,6 per mille), cui si somma il calo, più contenuto, registrato da quella migratoria (-0,9 per mille). Il tasso di crescita naturale è negativo in tutte le province. Quello migratorio invece registra dinamiche di segno opposto in alcuni territori, e in particolare nella provincia di Caserta, dove è positivo e contribuisce al pareggio del bilancio demografico 2023.
Il numero medio di figli per donna (1,29 nel 2023) è leggermente più alto della media nazionale e della ripartizione di appartenenza (rispettivamente 1,20 e 1,24), con una discreta variabilità sul territorio (da 1,14 della provincia di Avellino a 1,34 di Caserta). La struttura per età, con un indice di vecchiaia di 155, anziani (65 anni e oltre) per 100 persone di 0-14 anni, è decisamente meno sbilanciata che a livello nazionale (200 ogni cento), grazie alla maggiore incidenza tra i residenti in regione di persone tra 0 e 14 anni di età e alla più bassa quota di anziani 65+.
La provincia di Benevento presenta il maggiore squilibrio intergenerazionale pari a 213 anziani ogni cento giovani; nella provincia di Caserta si registra l’indice più basso (139). I residenti di cittadinanza straniera sono il 4,7% della popolazione regionale (4,3 punti percentuali in meno della media nazionale) con le incidenze maggiori nelle province di Caserta e Salerno (rispettivamente 5,9 e 5,2%). Il sistema produttivo regionale presenta una vocazione nel settore terziario, con il 76% di occupati, quota più elevata di quella nazionale (73,2%).
Nella città metropolitana di NAPOLI si ha la maggiore specializzazione occupazionale nei servizi (79,3%degli occupati). Le province di Caserta e Salerno registrano un peso del terziario (rispettivamente 73,7 e 73,4% degli occupati) pressoché in linea con la media-Italia. La provincia di Avellino è la più vocata nell’industria in senso stretto con una quota di occupati (17,5%) maggiore della media-Italia, mentre le altre province si collocano tutte sotto il valore nazionale e sono piuttosto omogenee fra di loro, non superando il 13% degli occupati. Una maggiore componente agricola è caratteristica delle province di Benevento (9,3) e Salerno (6,4), dove l’importanza del comparto è tale da superare decisamente non solo il valore regionale, ma anche quello nazionale (3,6 in entrambi i casi).
Nel 2021, ultimo anno di riferimento delle stime disponibili a livello provinciale e secondo anno della pandemia, l’economia campana ha generato un valore aggiunto di 100.197 euro (valori correnti), il 6,1% del valore aggiunto nazionale. In termini pro-capite si è prodotta una ricchezza pari a circa 17.815 euro per abitante e a 53.641 euro per occupato. Entrambi gli indicatori posizionano la regione vicino al dato della ripartizione (18.283 e 53.476 rispettivamente) ma lontano da quello nazionale di confronto (27.688 e 65.031). I livelli minimi regionali si trovano nella provincia di Caserta per il valore aggiunto per abitante (16.353), e nella provincia di Avellino per il valore aggiunto per occupato (48.536), mentre la città metropolitana di NAPOLIpresenta i risultati migliori fra le province campane (18.363 e 56.047 euro).
Nel 2021, conclude il rapporto, il comparto industriale e dei servizi (esclusa la Pubblica Amministrazione) conta 367.475 imprese attive localizzate in Campania e 397.743 unità locali (u.l.), circa l’8% del totale nazionale e il 28% circa del Mezzogiorno. La dimensione media delle u.l. (3,0 addetti) è uguale al valore del Mezzogiorno e più bassa di quello nazionale (3,6). In termini relativi, in Campania sono attive circa 107,5 unità locali di imprese ogni mille abitanti di 15-64 anni; anche il valore di questo indicatore di densità imprenditoriale è più basso in confronto all’Italia (130,9) e al Mezzogiorno (108,9). Fra le province la densità è maggiore a Salerno e Benevento (120,4 e 119,3).

 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa